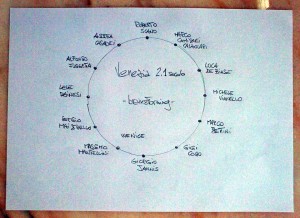Immaginate la frustrazione di chi, come me, da quindici anni prova a raccontare scrivendo parlando o facendo formazione cosa significhi internet per la nostra generazione di “traghettatori” culturali, in previsione del significato che questo cambiamento epocale avrà per le prossime generazioni.
Immaginate i sorrisini di assessori regionali, sindaci, dirigenti scolastici, insegnanti, genitori dinanzi a un fanatico capellone (son sempre io) che si intestardisce nel promuovere Cultura Tecnologica e Digitale, nella convinzione che conoscere il funzionamento delle cose sia la mossa migliore per comprenderle e prevenire gli eventuali problemi che possono sorgere, a partire dalla gestione del territorio quale Oggetto tecnologico di cui siamo ecologicamente responsabili, passando attraverso le considerazioni sul risvolto antropologico dell’abitare, per arrivare alla promozione di consapevolezza rispetto alle nuove dinamiche della socialità in Rete.
Nel frattempo, il mondo è cambiato profondamente. Quindici anni fa cellulari e web praticamente non esistevano. Oggi in italia ci sono più cellulari che abitanti, e 10.000.000 dieci milioni di italiani chiacchierano e scherzano su facebook, molti altri rimpiazzano ormai la tv con youtube (quattro anni fa non esisteva), lavorano dentro la Rete o comunque non riescono più a concepire il proprio lavoro o lo studio senza un pc connesso a portata di mano, partecipano alle politiche locali, ricavano identità personale e collettiva dall’appartenenza a Luoghi digitali, s’informano sugli eventi del mondo e abitano tranquillamente nei nuovi Luoghi della socialità umana.
Le istituzioni stanno (lentamente) modificando sé stesse, per garantire forme di abitanza digitale come e-government ed e-democracy ormai attestate come diritti del cittadino, le imprese e il mondo delle professioni riconoscono l’assoluta centralità delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per l’ottimizzazione dei sistemi produttivi e distributivi di beni e servizi, la Cultura tutta, fatta di idee e opinioni e rappresentazioni, vive dentro la Rete, perché la Rete è la Cultura umana, che fino a ieri trovava supporto nei media cartacei o di celluloide, e oggi si trova assai più comoda in un ambiente fatto apposta per sostenere la Conoscenza. Le idee si propagano da sempre come virus nella socialità umana, noi abitiamo dentro i linguaggi con cui nominiamo il mondo, e oggi le reti planetarie rendono più facile e potente la comunicazione tra le persone. Tutto qui.
Certo, se i massmedia italiani, diversamente da altre parti d’Europa, continuano a trattare con sufficienza e sorrisini altezzosi o con toni scandalistici le forme di abitanza digitale dentro cui loro stessi sono coinvolti (e i quotidiani e i telegiornali italiani in questi ultimi mesi si sono accorti di dover “cambiare per non morire”, vista l’insostenibilità economica dei modelli tradizionali del fare informazione), risulterà più faticoso mostrare le opportunità civiche di miglioramento qualitativo dell’abitare rese praticabili dai nuovi strumenti della socialità umana.
E non esiste nessun “popolo della Rete”, come dicono i giornali: quelle persone siamo noi, normali cittadini, metà o più della popolazione italiana (e solo la miopia culturale e politica ha impedito e impedisce tuttora la riduzione banalmente tecnica del digital divide, altrimenti saremmo molti di più), che ritengono la frequentazione della Rete una normale pratica quotidiana, ludica o professionale, e soprattutto considerano il web una risorsa preziosa per vivere meglio.
Il tempo è galantuomo, dicono, e già qui intorno ho visto spegnersi molti sorrisini di sufficienza; la frustrazione di non essere compresi svanisce nel vedere il mondo cambiare nelle direzioni prefigurate molti anni fa. Abbiam perso delle occasioni, ma molto lavoro è ancora da fare per costruire la consapevolezza diffusa del nostro abitare biodigitale. Questo è anche il vantaggio di sapere di essere nuoviabitanti, e di poterlo scrivere su un blog intitolato NuoviAbitanti. Già molte volte ho affrontato su questo blog di questi argomenti: per amor di varietà segnalo quindi la prefazione del nuovo libro di Luca Sofri “Nati con la rete” pubblicato da Rizzoli, in uscita in questi giorni.
via Luca Sofri
Tardivi digitali
Le persone non più giovani che si accingano a voler capire com’è il mondo delle generazioni «native» devono innanzitutto liberarsi della solida sensazione di essere i protagonisti del nostro mondo e del nostro tempo: inutile illudersi, non lo sono più. E devono liberarsi dall’inclinazione «entomologica» nei confronti dei fenomeni che riguardano i loro figli (o nipoti): noi non siamo scienziati che studiano gli insetti, siamo insetti che studiano gli scienziati, per quanto insetti curiosi e colti, colti di un’altra vecchia cultura. Le nostre analisi le pubblichiamo ancora sui libri di carta e di centinaia di pagine, come questo. E non ci è facile pensare agli adolescenti e ai ventenni come al mondo che è già: lo consideriamo il mondo che sarà, appena ci toglieremo di torno noialtri. Ma il mondo ci ha già tolto di torno: ne frequentiamo uno che risulta sempre più emarginato, illuso da una grande finzione collettiva tenuta in vita dai mezzi di comunicazione che a loro volta gli appartengono e che con lui se ne stanno andando.
È la fine del mondo come lo conosciamo. O almeno lo sarebbe.
Perché rispetto a questo è interessante fare anche un’altra riflessione, simmetrica a quella sui nativi digitali ospitata in questo libro. Ed è quella sul rapporto con la rete di noi non nativi.
Noialtri non nativi apparteniamo a due distinte categorie (trascuro quelli che con internet non hanno ancora avuto mai a che fare, vuoi per sfortuna geografica e sociale, vuoi per età, vuoi per rarissima ostinazione). Ci sono da una parte quelli vengono chiamati «coloni», o «immigrati», o «ibridi». Io preferisco l’ultimo termine, perché descrive la condizione – che è anche la mia – di persone che sono vecchie abbastanza da aver frequentato il mondo «di prima», ma anche giovani abbastanza da avere abitato da subito il mondo «di dopo». È una categoria umana ridotta, per ragioni anagrafiche, ma centrale nella costruzione della conoscenza, della cultura e delle elaborazioni relative alla rete: perché ne ha seguito nascita e crescita avendo già gli strumenti per capirla e discuterla, e il metro per tenerla in relazione con il mondo «di prima». Ne sono stati protagonisti negli scorsi anni, ma ormai la loro presenza si sta ridimensionando mentre avanzano e si allargano i nativi che bene interpreta e descrive Nati con la rete. Ma c’è un’altra avanzata che ha riversato in rete una popolazione nuova in questi ultimissimi tempi.
La chiamerei quella dei «tardivi» di internet: la seconda categoria di non nativi. Sono coloro che hanno cominciato a occupare e a occuparsi di internet solo da poco, di fatto, e soprattutto grazie alla nuova accessibilità e familiarità di alcuni suoi luoghi e prodotti.
Succede con molti fenomeni nuovi. Ci sono delle avanguardie di esploratori che raggiungono e colonizzano luoghi prima inesistenti o sconosciuti. Il west. Uomini in cerca di qualcosa e con poco da perdere si spingono in là senza sapere cosa troveranno: sparano ai bisonti, trattano con gli indiani, dormono intorno al fuoco acceso sotto le stelle e con un occhio aperto. Si adattano al nuovo mondo e ne scoprono le opportunità, a forza di tentativi e fallimenti. Colonizzano, appunto.
Più tardi, quando gli indiani sono stati allontanati e le praterie sono state liberate dai bisonti, c’è uno sceriffo ed è arrivata la ferrovia, gruppi sempre più numerosi di nuovi coloni cominciano ad arrivare. Arrivano con le carovane, traslocando le loro cose, e trovano già i pozzi e l’acqua corrente. C’è una maestra, un saloon e un bordello. Trovano il loro mondo, solo spostato da un’altra parte. Ma si guardano intorno e dicono «qui è davvero un altro mondo».
Questo sta succedendo con internet, in particolare in Italia. Per anni una piccola comunità di esploratori ha provato – spesso riuscendoci – a inventarsi cose nuove che si potessero fare con la rete, e ha costruito un mondo, anche se era un mondo frequentato da pochi. Altri provavano a trapiantare in rete attività e servizi più tradizionali, ma i clienti più tradizionali non erano ancora arrivati. I lettori dei giornali leggevano ancora i giornali, non i giornali online. Poi però hanno cominciato ad arrivare, ad avvicinarsi, ad affacciarsi guardinghi. E a un certo punto hanno trovato Facebook. E sono entrati.
No, non è solo Facebook. Sono molti i luoghi della rete in cui la differenza dal mondo di prima è praticamente inesistente, quasi invisibile, come quando si va in vacanza in un Paese esotico e diverso e si trova una pizzeria italiana, o un McDonald’s. Un esempio facile e interessante è il successo di un sito di pettegolezzi, voci e rassegna stampa dedicate alle celebrities e ai poteri italiani. Tecnicamente un blog, ovvero una delle forme più moderne e rivoluzionarie della comunicazione online. Ma le opportunità sono tarpate, ignorate, tenute alla larga. Non esistono di fatto link, si tratta di un contenitore di testi, come un giornale tradizionale. Non crea relazioni con altri luoghi della rete, è un posto isolato da internet. E ospita da sempre contenuti familiari, propri dell’establishment dell’informazione italiana, quasi vernacolari. È internet per i navigati direttori della stampa nazionale: gossip, vicende di potere bancario e politico, economico e giornalistico. Aggressività verbale, linguaggio spiccio e burineggiante, e notizie pubblicate con secondi e terzi fini. C’era persino il porno, fino a poco fa (il porno è eterno). Tutta l’Italia più zavorrata nel secolo scorso. E che però ha trovato se stessa su un blog, e si è convinta che quello fosse internet.
Si possono fare altri esempi. Il blog italiano più seguito e pubblicizzato negli ultimi due anni è in realtà un altro esempio di sfruttamento poverissimo e semplificato delle opportunità tecniche e relazionali della rete. Niente più di una rubrica su un giornale, con l’aggiunta dei commenti, ma un’aggiunta assolutamente non esaltata o sfruttata. Una sorta di lunga rubrica delle lettere. E ammesso che l’autore le legga (sono centinaia), non le usa, non risponde. Anche lui non si mette in relazione con la rete, non la sfrutta. Non mi fraintendete: si tratta di un successo di lettori e mediatico formidabile, indiscutibile e ammirevole. Ma è un successo che si deve appunto alla familiarità e accessibilità dell’iniziativa. E che anzi probabilmente non sarebbe stato ottenuto lavorando a un’idea più ricca, creativa, condivisa, più fatta a forma di internet. Il blog più seguito in italia ha attratto i lettori estranei agli altri blog: non solo per l’efficacia di quel che dice, ma anche appunto per la sua forma «accogliente», facile.
E poi è arrivato Facebook. Una consolante rivelazione, per i tardivi digitali. È un luogo della rete del tutto familiare, quasi da film di Pupi Avati: ci si scambiano le fotografie, si ritrovano i vecchi compagni di scuola (si fa molto altro, ma su questi due servizi si è basato il grosso della comunicazione propria del social network). Chi accede alla rete da Facebook non ha bisogno di conoscere i meccanismi con cui la rete funziona o di essere appassionato dell’informazione e delle cose del mondo. Ci trova quelle cose che lo interessano e che conosce. Giovanni Boccia Artieri, studioso della comunicazione, ha individuato nel successo di Facebook «l’ascesa della borghesia» in rete. E questo non solo significa che i meccanismi della rete coinvolgono sempre più persone che prima ne erano estranee, ma ha anche un effetto opposto. Internet si «normalizza». Viene ricolonizzata dal mondo di prima. I suoi nuovi abitanti, meno coraggiosi e attrezzati, vi ricostruiscono i modelli familiari. Il successo di Facebook è un successo di funzioni semplici e tradizionali: relazioni con vecchi compagni di scuola, album di ricordi, piccole conversazioni, campagne per i cani abbandonati, promozioni editoriali.
L’accesso alla rete e la sua colonizzazione da parte dei tardivi non si deve per forza prestare a una valutazione, se sia un bene o un male. È una cosa che sta accadendo, inevitabilmente, e con cui è il caso di fare i conti. Ed è ovviamente una buona cosa, come ogni crescita dell’accesso alla rete e a qualsiasi nuovo mezzo di comunicazione in genere. Ha anche delle controindicazioni, per i modi descritti con cui sta avvenendo. Quello che da parte dei tardivi era una volta un atteggiamento di laica e umile curiosità nei confronti di internet si sta trasformando in una rapida sopravvalutazione della propria esperienza. Tornando agli esempi di cui sopra, è accaduto in molte redazioni di giornali che si siano scambiati siti di gossip per un esempio della nuova informazione online e che si siano presi blog politicizzati per una moderna forma di aggregazione e attività politica in rete. Per molti, la punta dell’iceberg di internet citata dai giornali è diventata la propria idea di internet (quindi aggiungeteci bullismo su YouTube, saccheggi della privacy e tutto il repertorio dell’allarmismo giornalistico: spaventalismo). Fino a che non è arrivato Facebook, che è diventato internet. L’espansione di Facebook dentro la rete è stata molto dibattuta in questi mesi: Facebook si allarga e i suoi meccanismi semplificati sottraggono spazio ai servizi e ai siti più ricchi e promettenti. E molte persone che per la prima volta accedono a Facebook attratte da questa semplificazione sono vittime di una sbornia adolescenziale simile a quella dei nativi quando scoprono un nuovo straordinario e fantascientifico videogame online. Si apre loro un mondo, e lo capiscono. Accumulano amici, reinventano le proprie relazioni e il loro tempo libero, scambiano Facebook per l’universo, e la grande rivoluzione tecnologica di questi decenni gli è improvvisamente chiara nella sua generosità: era Facebook. Questa sopravvalutazione ha un limite, come dicevo: impedire che questo primo e facile accesso alla rete preluda a nuove scoperte e nuove opportunità. Questo è ciò che avviene per i nativi, che allargano col tempo sempre di più gli usi della rete e gli spazi che ne conoscono. I tardivi invece confrontano i misteri della rete con i confortevoli luoghi di cui hanno esperienza, e ne stanno alla larga. Per alcuni di loro, questa ritardata emozionante scoperta si traduce rapidamente in elaborazioni, considerazioni, idee, e persino progetti imprenditoriali in ritardo di anni su quanto la rete ha già discusso e analizzato e creato prima. Ma questo potrebbe non significare niente, perché ormai una cospicua parte degli interlocutori o degli utenti di queste idee è a sua volta tardiva, soprattutto in Italia. E così come la televisione italiana non può che produrre contenuti anacronistici e arretrati dipendenti dal suo tipo di pubblico, anche la rete potrebbe rischiare di essere trascinata indietro da ragioni di mercato nuove. Miss Italia su internet potrebbe diventare un grande successo nel 2011. Magari persino il Festival di Sanremo, o l’edizione online di «Micromega».
Oppure no. Oppure ci salveranno i nativi. Anzi salveranno se stessi. La rete è l’ultimo luogo che ci rimane per tenere le redini del futuro, in un Paese così per vecchi da essere diventato un cliché. Ed è un luogo in cui molti si rammaricano non si trovino dei modelli di business adeguati a sfruttare iniziative anche di grande successo di visite e utenti. E proprio questo potrebbe essere un’opportunità per scongiurarle il melmoso destino in cui si dimena il resto del Paese. L’Italia salvata dai nativi digitali.