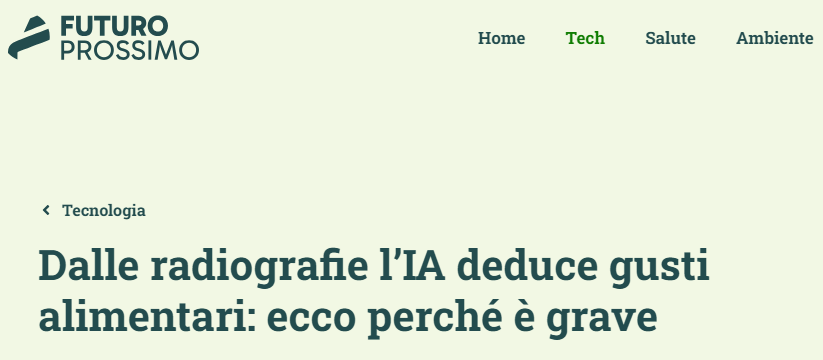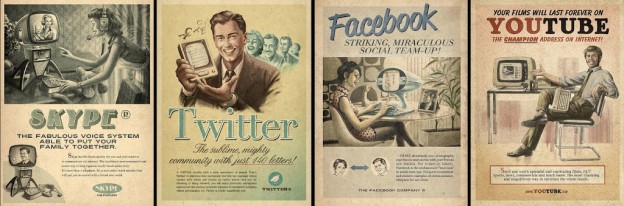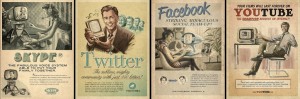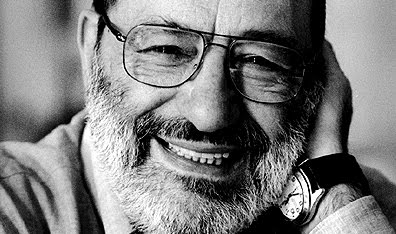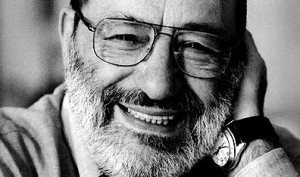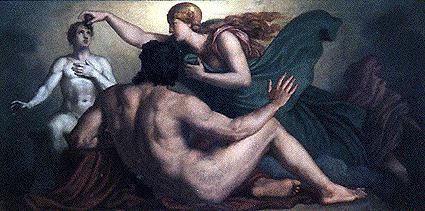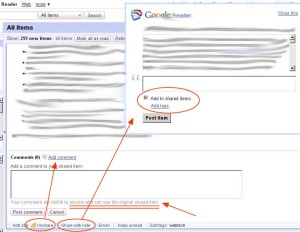Ci sono da sempre, in ogni tempo, fenomeni sociali in elaborazione profonda, di cui non siamo consapevoli. Mancano parole per etichettarli e comprenderli, per portarli alla percezione e alla comprensione, alla diffusione. Come la punta dell’iceberg, dove in realtà ci sfugge la massa colossale di quanto è sotto la superficie del mare, in questo caso ci sfugge quell’agitarsi di parole, ideologie, processi, prassi sociali che vivono sotto la soglia della coscienza collettiva. Forse presenti, non ancora tematizzati, soltanto nei gesti o nei pensieri di qualcuno; forse approcci soltanto verbalmente espressi nei piccoli gruppi (la “cinghia di trasmissione” delle innovazioni sociali, dall’individuo alle masse) nei bar o nei circoli esclusivi che poi diventavano manoscritti o pamphlet o manifesti, ma di certo non subito resi noti tramite pubblicazioni o diffusione sui massmedia come oggi, per diventar alla fine (“il destino di un segno è fissarsi in una credenza”, C.S. Peirce, a memoria) dopo lungo cammino possesso stabile dell’opinione pubblica.
Se vogliamo abbiamo quella famosa frase di Victor Hugo per svelare la questione, ovvero che “niente è più irresistibile di un’idea il cui tempo sia giunto”, oppure quell’ottimo concetto della “finestra di Overton”, per provare a descrivere i meccanismi della comparsa e dell’accettazione sociale delle idee innovative, in quella che propriamente può essere analizzata come Storia delle idee, dignitosissima disciplina anche accademica, purtroppo assai trascurata.
Il concetto emergente per la comprensione della realtà sociopolitica odierna, in termini planetari, è “accelerazionismo”.
L’accelerazionismo si manifesta, nel panorama politico e sociale contemporaneo, in diverse forme e con obiettivi spesso contrastanti. Non è più relegato a circoli filosofici o marginali, ma sta trovando eco in dibattiti più ampi e influenzando, in modi a volte sottili e a volte più espliciti, movimenti e ideologie, nonché le scelte politiche attuali. Una delle ragioni della sua crescente rilevanza risiede nella diffusa sensazione di insoddisfazione nei confronti dello status quo, per quelli che percepiscono una sorta di lentezza o un’incapacità dei sistemi politici tradizionali di affrontare sfide globali urgenti come il cambiamento climatico, le disuguaglianze economiche o l’impatto delle nuove tecnologie. Per chi pensa di avere le soluzioni e vuole comandare, senza mezzi termini, la democrazia stessa è vista come un ostacolo, o per lo meno come un metodo obsoleto per la gestione delle società umane.
In questo contesto, l’idea di “accelerare” i processi, di forzare un cambiamento radicale piuttosto che affidarsi a riforme graduali, acquista un certo fascino per chi è frustrato dalla lentezza del progresso o, al contrario, teme un declino inarrestabile.
L’accelerazionismo non è un’ideologia monolitica. Esistono diverse correnti, spesso in tensione tra loro. Un filone, spesso definito di “sinistra”, mira ad accelerare le contraddizioni del capitalismo per giungere a un superamento del sistema stesso e all’instaurazione di modelli sociali più egualitari e sostenibili. Questo filone può guardare alle potenzialità trasformative delle tecnologie o alle dinamiche di conflitto sociale come motori di un cambiamento necessario. C’è tutta una genealogia dei pensatori che hanno contribuito alla focalizzazione di questo approccio, da Bogdanov a Deleuze e Guattari della de-territorializzazione, ai più recenti e necessari Mark Fisher nonché Nick Srnicek e Alex Williams di “Inventare il futuro”.
Ma qui abbiamo a che fare ora con il lato oscuro, l’accelerazionismo di destra di Nick Land e di Curtis Yarvin, di Peter Thiel e di Elon Musk, la negazione della democrazia a favore di oligarchie facoltose, di superamento delle strutture sociali faticosamente e sanguinosamente conquistate nel corso del Novecento (tribunali, parlamenti, diritti civili) verso forme di organizzazione della collettività mutuate da impostazioni aziendali o militari, con rigide gerarchie di comando.
Il Dark Enlightenment, Illuminismo Oscuro, emerge come una corrente di pensiero critico e neo-reazionario nei confronti dei pilastri della modernità. In questa prospettiva, la democrazia liberale non è vista come un ideale compiuto, bensì come un sistema imperfetto, incline all’inefficienza e potenzialmente autodistruttivo, dove le decisioni sono spesso il risultato di dinamiche di massa o di influenze particolari, piuttosto che di una razionalità illuminata appannaggio di menti superiori.
Si manifesta con una certa nostalgia o ammirazione per forme di governo che si percepiscono come più ordinate e capaci di azione, come monarchie o modelli tecnocratici – sorta di tecnofeudalesimo che molti oggi vorrebbero vedere realizzato – in cui si presume una maggiore competenza decisionale e una visione strategica più definita.
L’idea stessa di eguaglianza viene messa in dubbio o dichiaratamente respinta, con argomentazioni che talvolta sfociano nel riconoscimento di gerarchie intrinseche, basate su presunte differenze di capacità o intelletto. Un filo conduttore significativo è la preoccupazione per un presunto declino culturale e sociale dell’Occidente, attribuito a fenomeni complessi come il multiculturalismo, i flussi migratori e una percepita erosione dei valori tradizionali. In questo quadro, si osserva un’enfasi sulla razionalità e sulla scienza, sebbene spesso interpretate attraverso una lente selettiva che tende a supportare argomentazioni relative a differenze innate tra gruppi umani. Non è difficile riconoscere come molte delle sue premesse e conclusioni siano insomma considerate da più parti come portatrici di istanze razziste, sessiste e intrinsecamente antidemocratiche.
Riflettendo sull’accelerazionismo di destra in relazione al Dark Enlightenment, si nota che le contraddizioni e le debolezze intrinseche della modernità debbano essere esacerbate, portate al loro punto di rottura, per far emergere un ordine sociale ritenuto superiore. Il Dark Enlightenment fornisce spesso un’analisi “diagnostica” di questo presunto declino e suggerisce, implicitamente o esplicitamente, la necessità di un cambiamento radicale di paradigma politico e sociale spingendo attivamente verso una crisi sistemica che possa aprire la strada a nuove forme di organizzazione sociale e politica, ispirate a modelli gerarchici e autoritari evocati dal pensiero neo-reazionario.