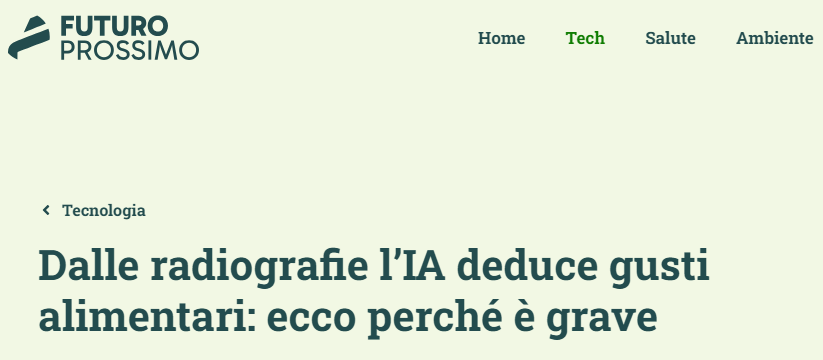L’intelligenza artificiale come strumento di tutela e promozione del friulano: una prospettiva innovativa
La sfida del tempo
Le lingue minoritarie europee, tra cui il friulano, si trovano dinanzi a una sfida epocale: competere con le lingue dominanti in un contesto di globalizzazione, pur disponendo di strumenti limitati per farlo. La posta in gioco non è solo culturale, ma anche politica ed economica, poiché una lingua che scompare porta con sé un intero sistema di conoscenze, relazioni e opportunità. L’intelligenza artificiale, spesso percepita come forza omologante, potrebbe invece diventare un’alleata insospettabile nella tutela e promozione del friulano.
Il friulano presenta una frammentazione dialettale significativa. L’IA offre soluzioni concrete per superare questa criticità. La raccolta automatizzata di corpora linguistici attraverso sistemi di NLP (Natural Language Processing) può analizzare testi storici, registrazioni orali e produzioni contemporanee, identificando pattern comuni e divergenze. Questo processo consente di creare una sorta di “memoria digitale”, nonché grammatiche predittive basate sull’uso reale della lingua friulana, piuttosto che su imposizioni accademiche. Inoltre, l’archiviazione dinamica su piattaforme open-source può mappare le varianti locali, trasformando la diversità da problema a ricchezza.
Un esempio concreto è il progetto Resia dell’Università di Udine, che ha digitalizzato 10.000 pagine di letteratura friulana, che però andrebbero organizzate efficacemente per aree geografiche e temi con algoritmi avanzati.
Nell’educazione, l’insegnamento del friulano nelle scuole, previsto dalla Legge Regionale 29/2007, soffre di carenze strutturali: docenti non formati, materiali obsoleti e scarsa attrattività per i giovani. L’IA può rivoluzionare questo ambito attraverso l’impiego di app di apprendimento adattivo. Piattaforme come Duolingo o Memrise, customizzate per il friulano, potrebbero adattarsi al livello e al dialetto dello studente, utilizzando il riconoscimento vocale per correggere la pronuncia. Inoltre, tutor virtuali basati su chatbot conversazionali potrebbero simulare dialoghi quotidiani, rendendo l’apprendimento interattivo e coinvolgente. La gamification, con sistemi di reward basati su IA, incentiverebbe i giovani a usare la lingua in contesti digitali, come videogiochi con narrazioni in friulano.
In ogni caso la realizzazione di questi progetti richiede investimenti significativi per creare dataset di qualità. Il progetto basco “Berdin”, con 200 ore di audio annotato, dimostra che è possibile raggiungere risultati tangibili, ma necessita di una collaborazione stretta tra istituzioni e comunità.
Digital Divide e Nuovi Spazi Pubblici
Il friulano è quasi assente nel digitale, con meno dello 0,01% dei contenuti online in questa lingua (dati Euromosaic). L’intelligenza artificiale potrebbe modificare la situazione integrando al meglio il friulano in strumenti di traduzione automatica come DeepL o Google Translate (già presente, ma con evidenti limiti), sfruttando modelli “low-resource” addestrati con piccoli dataset. Inoltre, la generazione di contenuti multimediali, come audiolibri o podcast con voci sintetiche che riproducono accenti locali, potrebbe aumentare la visibilità della lingua. Un caso studio interessante è l’app “SaySomethingInWelsh”, che ha aumentato del 30% i parlanti under 35 in Galles. Perché non replicare un simile successo con un progetto analogo per il friulano?
In realtà anche nelle politiche linguistiche servono dati per decidere. Le istituzioni spesso agiscono al buio, mancando di strumenti decisionali precisi. L’IA può fornire dati in tempo reale per monitorare l’uso del friulano nei social media e nei testi su web, mappando dove e come si parla questa lingua. Inoltre, simulazioni di policy basate su modelli predittivi potrebbero testare l’impatto di leggi o finanziamenti, aiutando a ottimizzare le risorse disponibili. La comunicazione mirata, con chatbot per uffici pubblici in friulano, garantirebbe accesso ai servizi nella lingua madre, migliorando l’inclusione sociale.
Un esempio virtuoso è il sistema “Plataforma per la Llengua” in Catalogna, che usa l’IA per analizzare la presenza del catalano nei media, spingendo riforme legislative.
L’entusiasmo per l’IA non deve in ogni caso oscurare i pericoli potenziali: l’appiattimento linguistico è un rischio reale se un modello IA addestrato sul friulano “standard” marginalizzasse le varianti locali. Sarebbe inoltre eticamente significativo mantenere sempre alta l’attenzione sugli algoritmi utilizzati per evitare forme di dipendenza tecnologica
Serve un piano di intervento per le politiche linguistiche aumentate, certo. L’IA non salverà il friulano da sola, ma offre strumenti senza precedenti per la sua tutela e promozione. Servono finanziamenti mirati, come quelli previsti da Horizon Europe e PNRR, che includono fondi per il digitale e le lingue minoritarie. È fondamentale una co-progettazione con i parlanti, coinvolgendo associazioni e agenzie linguistiche e formative, per evitare soluzioni calate dall’alto. Una strategia transnazionale che collabori con realtà che lavorano su altre lingue minoritarie (es. occitano, sardo) potrebbe condividere modelli e risorse, massimizzando l’impatto.
In sintesi, l’IA non è la bacchetta magica per rivitalizzare il friulano, ma una leva per trasformare la tutela linguistica da mera conservazione a innovazione attiva. Il tempo stringe: secondo l’UNESCO, il 40% delle lingue mondiali rischia l’estinzione entro il 2100. Per il friulano, la scelta è tra l’adattarsi o diventare un reperto da museo. L’intelligenza artificiale, ironia della sorte, potrebbe essere l’elemento più “umano” di questa battaglia.
Approfondimenti:
Il progetto “CLARIN” per le risorse linguistiche digitali, l’esperienza basca con “HiTZ Zentroa” (IA per l’euskara), e il modello di “Common Voice” di Mozilla per raccogliere dati vocali open-source, offrono esempi di come l’IA possa essere impiegata per le lingue minoritarie.