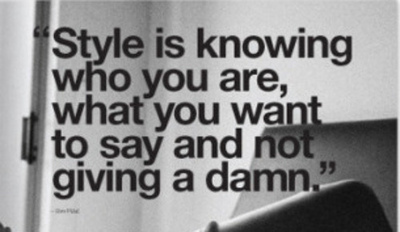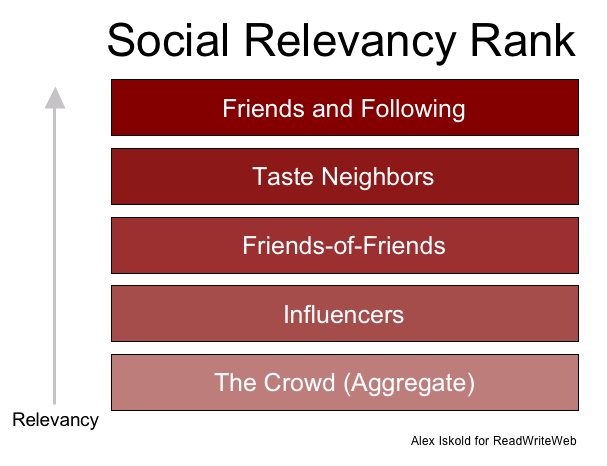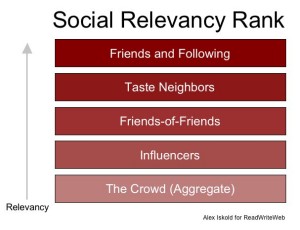Tra ieri e oggi sul web italiano sono apparse due novità, entrambe legate al mondo dell’informazione giornalistica. Luca Sofri ha varato
il Post, Gianluca Neri
Blognation.
Il primo assomiglia più a un “giornale online” (virgolette perché lo stesso autore dice quelle parole e subito se ne distanzia) con redazione e blog d’autore ospitati, il secondo è più un aggregatore, e Neri dice che funziona praticamente in automatico.
Grosse conversazioni in giro in Rete, ovvio, sull’evento, tra detrattori e entusiasti, consiglieri e critici.
Segnalo
Giuseppe Granieri, che dice che manca un colpo d’occhio generale su quale sia la linea del Post (e un giornale online deve appunto saperla comunicare, sennò si anonimizza e somiglia a un aggregatore), e
Andrea Beggi, che dice che non sa più leggere, che ormai è abituato alla serialità dei feed e ritrovare homepage (in entrambe le novità) che ricalcano l’impostazione di un quotidiano cartaceo risulta faticoso.
E ci sarebbero anche da linkare le discussioni su Friendfeed, dove si è dibattuto e sviscerato.
Ma in entrambi i commenti sottolineano credo il problema dell’interfaccia.
C’è un modello percettivo soggiacente alla strutturazione delle homepage dei quotidiani online (anche loro, Repubblica e Corriere a esempio, in fase di restyling grafico dei siti, proprio in questi giorni), dove ovviamente il riferimento corre alla prima pagina dei giornali cartacei.
Andando online, le redazioni giornalistiche hanno ricreato quello a cui eravamo abituati a incontrare tenendo in mano i quotidiani. E tralasciamo gli anni che hanno perso nel non dotarsi subito di webredazioni con professionalità specifiche. Poi è anche possibile, e sarebbe uno studio da fare, seguire come le homepage dei giornali nazionali si siano modificate nel tempo, forma e contenuti. Migliori impaginazioni, scelta degli argomenti da portare in evidenza, possibilità interattive, boxini morbosi e via dicendo. Che poi, non è che la prima pagina dei giornali sia stabile, ma cambia appunto anch’essa, e magari anche un po’ dal web ha imparato.
Ma a me interessa tornare su quella semantica dello spazio su cui si costruisce l’homepage di un quotidiano online.
Perché se dico che sotto c’è un modello percettivo, frutto del dialogo ormai secolare tra quotidiani e pubblico, dialogo dentro cui io sono nato e cresciuto, automaticamente mi trovo a parlare di aspettative del lettore.
E abbiamo il caso di un fruitore nuovo della Rete, che non resterà poi tanto disorientato dinanzi a Rep.it o al Post di Sofri, perché conosce quella grammatica.
Grandezza dei titoli, gerarchia d’importanza, occhielli, rimandi intratestuali, uso del colore, segni grafici originali, quadrati più o meno stondati, aree tematiche, uso di multimedialità.
Ma come dicono Granieri e soprattutto Beggi, se sei uno che in Rete ci vive da anni tutta quell’impostazione grafica è pesante. Quel modello percettivo, che vive dentro la testa e nella cultura di chi quel giornale lo fa come in chi lo legge, presuppone un certo atteggiamento cognitivo del lettore, ne pre-ordina lo sguardo, le traiettorie del senso, ne gestisce il tempo dell’esperienza, suggerisce affettività con un font aggraziato o con un ritmo di scrittura o con gli strilli dei titoli. Faticoso, pesante, autoriale, industriale, forse inconsapevolmente addirittura impositivo, nel dover fornire un sacco di coordinate. Non ne ho bisogno, ho altre fonti, ho altre aspettative.
Tenete presente: quando leggo il Messaggero Veneto, ogni mattina, mi sembra ogni volta di aver tra le mani un numero vecchio di giorni. Sono venuto a conoscenza ieri di tutte le news urlate nei titoli dell’edizione di oggi del quotidiano, e in ventiquattrore abitando in Rete quella notizia l’ho letta decine di volte, e magari ci ho letto sopra centinaia di commenti, io stesso ci ho ragionato a mia volta commentandola su un blog, e restando sintonizzato via feed via aggregatori via socialmedia.
Quindi: i quotidiani tradizionali si stanno impegnando a colonizzare il web, si stanno arrabattando (e molti stanno sbagliando, secondo Cultura digitale) a trovare nuove forme di remunerazione, è una questione di sopravvivenza. Hanno traslato nell’immateriale il loro modello di impaginazione, e stiamo oggi vedendo le modificazioni progressive di quest’ultimo, per meglio adattarsi a un diverso ecosistema della conoscenza, quello della Rete.
Ma chi nasce nuovo oggi, veramente non può fare altro che ripercorrere gli stessi modelli? Perché mi costringono a riattivare in me gli stessi codici comportamentali che automaticamente richiamo quando sono davanti a un pezzo di carta formato tabloid, nel momento in cui sono davanti a uno schermo? Davanti a quest’ultimo, ho altre abitudini. Il mio occhio, la mia mano sanno fare ormai quasi naturalmente cose che con la carta non posso fare. Seguo diversi percorsi di lettura, sono fruitore attivo, clicco e girovago e poi torno, segnalo e commento, ho dieci schede del browser aperte, abito un flusso, non sono al tavolino del caffè a leggere il giornale come accadeva nel 1907.
Se fai un aggregatore, fallo essenziale.
Se fai un giornale online, dammi una colonna di opinioni redazionali o autoriali, linka il resto, ma sii sempre essenziale.
Non dovrei neanche scrollare la pagina, per dire. E le pubblicità stringate anche quelle, in una colonna tutta per loro. Tanto nessuno in Rete le guarda, nessuno le clicca, e di chi le clicca non ho buona opinione.
Forse c’è di mezzo anche una questione legata a un approccio maggiormente visivo, rispetto a una strettamente testuale. Ma parlando di news, faccio due esempi di aggregatori:
Eufeeds e
Popurl. Uno basato proprio sui quotidiani nazionali, l’altro su quanto pubblicano le principali piattaforme di contenuto tipicamente web-based. Personalizzabili.
Il giornale che vorrei io aggiungerebbe semplicemente, mettendola in evidenza, una colonna con i contenuti originali sviluppati dalla redazione, troverebbe un buon titolista per le proprie e per le altrui notizie e relativi commenti, farebbe emergere come assolutamente significativo il proprio stile giornalistico, la propria personalità, il proprio punto di vista. Per il resto, lasciatemi libero di abitare a modo mio.
Update: costituisce novità odierna anche
Paperblog, localizzazione italiana di realtà francese, più focalizzata sui blog.