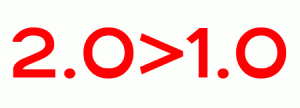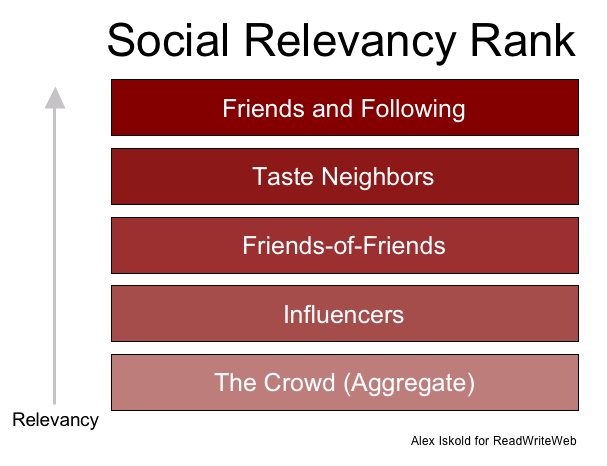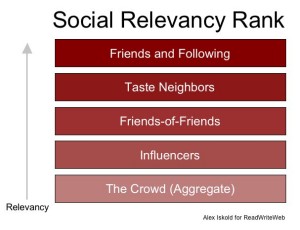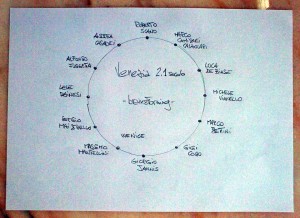Ecco cosa succederà! Questa blob informe della Sinistra italiana, ma spero tutti noi italiani amanti della verità, capiremo che l’idea che Berlusconi debba essere frontalmente messo a pubblico giudizio per il modo di condurre le attività imprenditoriali prima e per le leggi disinvoltamente da lui fatte approvare sulla sua stessa persona poi è esattamente la cosa da tradurre in pratica.
Senza perder tempo con la fuffa che ci sta intorno, al Fenomeno.
Fuffa che peraltro in altri paesi democratici porterebbe all’impeachment (quindi a processarlo), oppure muoverebbe dei capi di governo, ancora in possesso di una dignità personale, a farsi processare e a mettersi da parte.
Gli italiani vogliono sapere cosa pensa l’italia di Berlusconi, obiettivamente.
Ma questo deve essere frutto di una profonda presa di coscienza della collettività italiana, di tutti quelli che in testa riescono a concepire il pensiero di nazione – senza alcun retrogusto, questa parola, da intendere semplicemente come la forma di collettività che pensano questi italiani contemporanei quando pensano sé stessi come un tutto.
E allora chi ha a cuore la dignità dell’Italia, e qui lo scrivo maiuscolo perché è la mia idea di Italia e non la sua, dovrebbe riuscire a suscitare – magari andando in milioni intorno alle sedi rai, ma dico 15milioni di persone, ché non credo simile comportamento della società possa essere promosso dalle Istituzioni, in quanto esse stesse impegnate a difendersi – a produrre dicevo un colossale giudizio pubblico di tutti noi cittadini su Berlusconi, come una gigantesca nomination di un reality, realizzata per via mediatica prima e concretamente poi, votando. Su tutti i media italiani, e poi nei seggi. Tipo quando abbiam detto monarchia sì o no.
Un evento epocale, collettivo, per toglierlo di lì.
Innanzitutto si rendono gli italiani edotti sul contendere, sottolineando le malefatte del nostro personaggio villain, ed è sufficiente vedere cosa dice wikipedia nel riportare le tappe dell’ascesa, oppure gli elenchi delle sentenze giudiziarie dei processi, poi i vari lodi, spesso descritti in passato anche da giornalisti riconosciuti onesti nella loro visione, ancorati ai fatti, con ragionamenti su cui tutti possono concordare, tranne i fanatici. Tutte informazioni molto concrete, non opinabili.
Ebbene, la tv pubblica, i quotidiani tutti, i siti istituzionali governativi dovrebbero presentare agli italiani tutta la vita di Berlusconi, e dico letteralmente, senza parlare praticamente di altro, per dieci giorni e dieci notti, ripetendo continuamente a vari livelli discorsivi secondo comprensibilità e complessità le sue manovre negli ultimi quarant’anni, di modo che sia possibile fare chiarezza, e che a tutti sia chiaro chi è B. e cosa ha fatto in vita sua. Mostrare i fatti, nudi e crudi, e togliere la fuffa.
Se uno al bar dice “sì, ma forse lui…” gli si mostra subito la foto, un discorso scritto, il documentario, lo spezzone di un tg, il testo di una legge, insomma il documento stick-to-the-fact in cui il suo argomento oppositivo viene smentito.
Si organizza una costruzione collaborativa di una linea editoriale, tanto la linea registica da seguire è mostrare semplicemente i fatti della vita di una persona, e bisogna riuscire a pubblicare un racconto pulito, asciutto, concreto, anche asettico se serve, da parte di tutti i media italiani. Tutti i direttori dei quotidiani d’italia, e quelli delle televisioni, tutti insieme, e si stabilisce la linea per descrivere il Premier. E giornalisti e osservatori stranieri.
Ho ancora fiducia che si possa acclarare pubblicamente cosa sia una fatto reale, e distinguerlo da opinioni e dietrologie e drammi a tesi.
Tutti i media mostrano continuamente cose che parlino di lui, come sequenza ininterrotta di informazioni senza coloriture.
Tipicamente, voglio vedere la sua faccia su tanti televisori dentro le vetrine dei negozi, come in un filmone di una volta, e manifesti per strada che rechino scritta una qualsiasi delle sentenze pronunciate contro di lui, prese proprio da wikipedia.
Voglio che alla tv al posto degli spot pubblicitari, per dieci giorni, vengano fatti passare dei servizi giornalistici dove vengono ripetuti i capi d’accusa e la sentenza completa, viene illustrata la conseguenza delle sue leggi nel voler legittimamente procedere contro di lui.
Ogni pagina web editoriale dovrebbe pubblicare in home in alto un fatto random della berlusconeide, e parlare poi d’altro, dei rituali d’amore della coccinella peruviana.
I blog e i luoghi personali o riportano fatti, o tacciono. Sapere come la pensiamo tutti è più importante di sapere cosa ne pensa tizio o caio, per pochi giorni.
Se qualcuno sgarra, e crea un contenuto mediatico sbilanciato di qua o di là, tutti lo segnaliamo, e viene oscurato il sito o interrotta la pubblicazione per i giorni che mancano ai dieci da fare.
Chi sgarra è uno che vuole intorbidare le acque, che devono restare limpide per la formazione della coscienza, per una nascita di un’opinione pubblica.
La comunità internazionale ci controlla.
Dopo dieci giorni, lo avete capito, si vota. E si vota pubblicamente, con nome e cognome. E votano tutti, perché quelli che non vanno a votare o votano “mi va bene Berlusconi, anche se so che è antidemocratico, corruttore e mentitore” verrebbero subito visti e da tutti additati come persone che non attribuiscono i giusti significati nemmeno all’evidenza dei fatti, quindi o stupidi o persone interessate a negare la realtà, per una loro convenienza ben poco dignitosa.
E questa cosa dovrebbe essere detta di loro in ogni occasione pubblica, che sono esseri meschini.
Con segno di riconoscimento addosso, certo. Con un cartello sulla loro porta di casa, con un RFID nei loro vestiti. Ad esempio, obbligarli a tenere aperto un bluetooth che ti dà l’informazione sulla loro bassezza morale, o mettere un sottopancia quando passano in televisione o sul giornale o camminano per strada, così da sapere sempre che ho a che fare con gente che senza pudore nega la realtà, e che sostenendo una persona antidemocratica eccetera sono imputabili di eversione e apologia di reato. Lo farei per gli stupratori, per i pedofili, che han compiuto reati contro la persona, lo farei con quelli che dichiarano di voler agire contro la collettività, chi in questo caso avesse in sé lo squallore intellettuale ed etico di non voler considerare i fatti nel formulare il suo giudizio.
Una persona così non merita di essere ascoltata, nel suo parlare di come dovrebbero andare le cose. Non può parlare per gli altri, non può stabilire niente che mi riguardi, non la tengo in considerazione, non è un parlante ratificato nella conversazione civica.
Gogna, ma veramente pubblica, non da un potere centrale imposta, ma progettata e praticata collettivamente da tutti, nel segnalare subito (con un click, o chiamando i Vigili) chi esprime e propala una narrazione about berlusconi non conforme allo stile strettamente informativo. Per dieci giorni.
Poi tutta l’italia va a votare se vuole che quest’uomo del biscione abbia potere sull’identità pubblica e sui comportamenti istituzionali.
Perché, e qui sta il cuore del problema, io credo che qualunque italiano dinanzi ai fatti sia in grado di formarsi una propria rappresentazione della situazione, ma i fatti devono essere assolutamente neutri, come il tono di voce di Mike Bongiorno nel porgere la domanda a Rischiatutto.
Sarò ingenuo, ma fiducioso. E non credo che Berlusconi meriti una guerra civile.
Ho fiducia nel fatto che chiunque, indipendentemente dal proprio livello culturale e dalle proprie idee politiche, sappia comprendere i crudi fatti della realtà, e manifesti la propria volontà di abitare in uno Stato democratico.
E Berlusconi vedrete dovrà dimettersi da ogni carica pubblica, accettare di vedersi limato l’impero mediatico, vivere serenamente il suo futuro da imprenditore o da nonno, quietare la propria ambizione.
Se gli italiani si esprimono invece a favore di chi gioca barando, allora o sono stupidi o sono antidemocratici, e in entrambi i casi voglio in italia un commissariamento dell’Onu.



 Vedo che in giro periodicamente riprendono quota le discussioni sui nativi digitali.
Vedo che in giro periodicamente riprendono quota le discussioni sui nativi digitali.