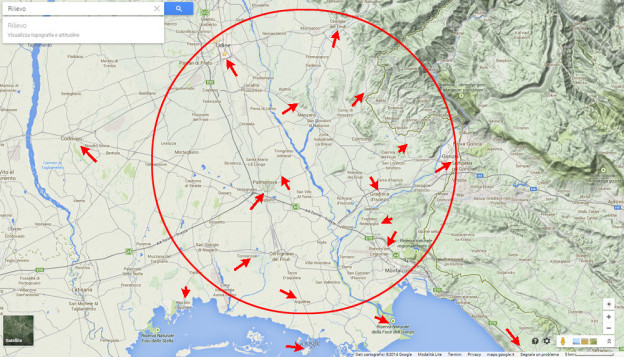Bifo, da qui
Rivolte nelle strade di Londra di Roma e di Atene, occupazione di centinaia di piazze nelle città spagnole. Quel che è accaduto tra l’autunno 2010 e la primavera 2011 non è stata un’improvvisa effimera esplosione di rabbia ma l’inizio di un processo che continuerà per anni e crescerà raccogliendo forza e visione strategica.
Un processo simile è iniziato nelle città arabe. Quella che vediamo là non è una rivoluzione per la democrazia, come dicono ipocritamente gli occidentali. Non è in vista nessuna democrazia nei paesi arabi, né alcun segnale di stabilizzazione post-rivoluzionaria. Quel che vediamo in Nord Africa come nel Medio Oriente è l’emergenza di una nuova composizione sociale fondata sul lavoro precario cognitivo, sull’intelligenza sociale collettiva che è sottoposta al dominio dell’ignoranza religiosa della privatizzazione economica e della corruzione. E’ l’inizio di una rivolta dilungo periodo destinata a convergere con quella europea.
Dieci anni fa, in seguito al dotcom crash che segnò la crisi della new economy, il semiocapitalismo finanziario iniziò lo smantellamento della forza politica dell’intelletto generale.
La privatizzazione delle risorse comuni della conoscenza e della tecnologia, la precarizzazione e lo sfruttamento crescente del lavoro cognitivo avanzarono insieme. Ora, in seguito al collasso finanziario del settembre 2008 il capitalismo finanziario ha lanciato l’aggressione finale. La spesa sociale viene tagliata, la scuola pubblica e l’università vengono distrutte, la ricerca è sottoposta a strategie di profitto di breve termine. L’insieme della società viene aggredita, impoverita, minacciata e umiliata, per imporle di pagare il debito accumulato dalla classe finanziaria.
Nei prossimi mesi le lotte sono destinate a proliferare radicalizzarsi. Questo è inevitabile, perché è la sola alternativa alla miseria e alla depressione generale.
Combatteremo uniti. Ma non basterà. Il problema che dobbiamo affrontare adesso è un problema d’immaginazione, non di forza. Cosa verrà fuori dalla insurrezione che si prepara in Europa?
Tutti vediamo il pericolo del crollo d’Europa: il ritorno dei peggiori incubi è già percepibile nell’espansione del nazionalismo del populismo mediatico e del razzismo nella psiche sociale.
L’assassino nazista di Oslo e i figuri leghisti che si riuniscono a Monza per celebrare i loro riti razzisti fanno parte dello stesso processo: la frustrazione ignorante e il fanatismo si saldano in una miscela tremenda di tipo nazista che è già forza di governo in paesi come l’Ungheria.
Cerchiamo di capire le premesse di questa situazione.
L’Unione Europea, che nel dopoguerra ha rappresentato una speranza di solidarietà sociale, negli anni della svolta neoliberista venne riprogrammata come congegno di governance monetarista, con una fissazione centrale: ridurre il costo del lavoro, ridurre la quota di reddito che va ai lavoratori.
In ossequio al nuovo dogma liberista e monetarista, nel 1993 venne costruito un dispositivo politico-finanziario che prese nome di Trattato di Maastricht.
Questo dispositivo comporta alcuni criteri che debbono essere rispettati dagli stati che non vogliano essere espulsi dall’UE. I criteri fondamentali sono questi:
Il rapporto tra deficit pubblico e PIL non deve essere superiore al 3%.
Il rapporto tra debito pubblico e PIL non deve essere superiore al 60% .
Il tasso d’inflazione non deve superare l’1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi.
Il tasso d’inflazione a lungo termine non deve essere superiore al 2% del tasso medio degli stessi tre Paesi.
L’ordine monetario dell’unione europea viene sottoposto alla supervisione della Banca Centrale Europea, il cui statuto prevede una completa autonomia rispetto alle decisioni del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, e stabilisce una finalità primaria dichiarata, che è quella di contenere l’inflazione.
Questo ferreo dispositivo giuridico-finanziario sul quale si fonda l’Unione Europea funziona come un automatismo che governa i processi di decisione politica e in ultima analisi costituisce un limite per le possibilità di immaginazione della società europea. Funziona in modo tale da costringere i paesi dell’Unione a ridurre il costo del lavoro, a ridurre la massa di risorse investite nel benessere della società, per contenere l’inflazione, per ridurre il deficit pubblico e per aumentare il profitto finanziario.
Naturalmente si potrebbero perseguire strategie differenti, come quella di tassare le transazioni finanziarie e di tassare i grandi patrimoni. Ma nel dispositivo neoliberista queste misure sono interdette, impronunciabili. Di conseguenza l’applicazione dei criteri di Maastricht ha prodotto negli ultimi due decenni uno spostamento gigantesco di risorse dal lavoro verso il capitale e dalla società verso la rendita finanziaria.
L’Europa è un continente ricco, ricchissimo. Milioni di tecnici, ingegneri, medici, progettisti, architetti, poeti, artigiani, biologi, insegnanti, donne e uomini di ingegno e cultura raffinata hanno reso questo continente agiato, comodo, piacevole. Da cinque secoli la borghesia, classe laboriosa e disciplinata ha progettato le città, le fabbriche, le strutture della vita civile. Una classe operaia vastissima, addestrata, qualificata e costretta alla disciplina ha innalzato ponti e grattacieli, prodotto milioni di macchine e macchinette.
Con la lotta sindacale e politica la classe operaia ha imposto alla borghesia di condividere parte della ricchezza prodotta, così che una parte vastissima della società europea ha potuto godere dei prodotti del lavoro industriale, e ha potuto avere accesso ai servizi che rendono la vita tollerabile, talvolta perfino piacevole.
Poi è arrivata la deregulation, la competizione internazionale si è fatta sempre più feroce, e la borghesia industriale ha dovuto cedere il posto di comando a una classe eterogenea, più spregiudicata e poliglotta, spesso arricchita grazie ad affari criminali, che detiene e maneggia un capitale immateriale, puramente semiotico: la classe detentrice del capitale finanziario.
Si tratta di una classe de territorializzata che possiamo definire come classe virtuale, in quanto essa sfugge all’identificazione fisica, territoriale, eppure i suoi movimenti e le sue scelte producono effetti visibilissimi nel corpo vivente della società. La classe finanziaria ha carattere virtuale perché essa non si presenta con un volto riconoscibile, ma piuttosto agisce come pulviscolo di innumerevoli scelte compiute da agenzie impersonali, come sciame guidato da una volontà inconsapevole.
Per quanto non identificabile e pulviscolare la classe de territorializzata della finanza sta imponendo all’Unione Europea il dogma secondo cui la società europea deve diventare povera, miserabile, infernale per essere competitivi sui mercati internazionali.
Il dispositivo Maastricht ha cominciato a funzionare come un sistema di automatismi tecno-finanziari il cui effetto è il contenimento e la riduzione della spesa sociale e l’aumento della rendita finanziaria.
Questi criteri non sono affatto naturali né inevitabili, ma neppure sono il risultato lineare di scelte politiche individuabili. Essi si impongono con la forza dell’automatismo. Possiamo definirli come dispositivo, cioè prodotto dell’azione umana che si sottrae alla volontà e si sovrappone all’azione umana, automatismo che pre-dispone l’azione umana a ripetere una procedura. Dopo il 2008, dopo la crisi dei mutui immobiliari americani e il successivo sconquasso della finanza occidentale, la rigidità dei criteri di Maastricht ha impedito qualsiasi flessibilità della decisione politica.
Il dispositivo Maastricht ha fatto fallimento. La crisi greca e tutto quel che segue é dimostrazione del fatto che questi criteri non hanno prodotto dei buoni risultati. Andrebbero rivisti, in modo da rilassare un po’ il respiro degli europei, in modo da restituire risorse alla società.
Ma l’autorità europea (che è un’autorità unicamente finanziaria, dal momento che l’autorità politica non conta niente) applica questi criteri in maniera tanto più fanatica quanto più fallimentare.
A partire dalla crisi greca della primavera 2010 l’effetto del dogmatismo neoliberista e monetarista è visibile: peggioramento delle condizioni di vita della società, aumento della disoccupazione, smantellamento delle strutture della vita civile e dei servizi sociali, insomma impoverimento generalizzato.
La classe finanziaria (le banche, le assicurazioni, il mercato borsistico), che pure hanno lucrato sul rischio (ad esempio imponendo alti interessi sui Credit Default Swaps) ora rifiutano di assumersi le conseguenze di quel rischio, e vogliono scaricarlo sulla società.
Per pagare il debito accumulato negli ultimi decenni dalla classe finanziaria, la società europea viene sottoposta a un dissanguamento generalizzato:
il sistema educativo, che costituisce il pilastro fondamentale per lo sviluppo civile, viene de finanziato, ridimensionato, impoverito, privatizzato in parte.
Il sistema sanitario viene definanziato e tendenzialmente privatizzato.
Le strutture di trasporto e di approvvigionamento energetico vengono privatizzate e quindi sottoposte a logiche economiche del tutto estranee ai bisogni della collettività e funzionali soltanto agli interessi del ceto finanziario, e agli obiettivi strategici della Banca centrale.
Insomma, la società europea viene drasticamente impoverita, tendenzialmente devastata e imbarbarita, pur di non scalfire il castello d’acciaio della cosiddetta stabilità finanziaria.
Se questo è il prezzo dell’adesione all’Unione Europea, presto nessuno vorrà più pagarlo, e allora si rischia il crollo dell’Unione, la cui conseguenza può essere la moltiplicazione dei populismi territorialisti e mediatici, il diffondersi della peste fascista e razzista ai quattro angoli del continente. l’Italia ha anticipato questa tendenza, con il lungo predominio del partito mafioso di Berlusconi e del partito razzista di Bossi.
L’insurrezione europea è nell’ordine dell’inevitabile. Il problema non è organizzarla, si organizza da sé. Il problema è immaginarne l’esito, costruire le istituzioni che rendano possibile l’autonomia della società dalla catastrofe inarrestabile dell’economia capitalista.
Bifo
25 luglio 2011