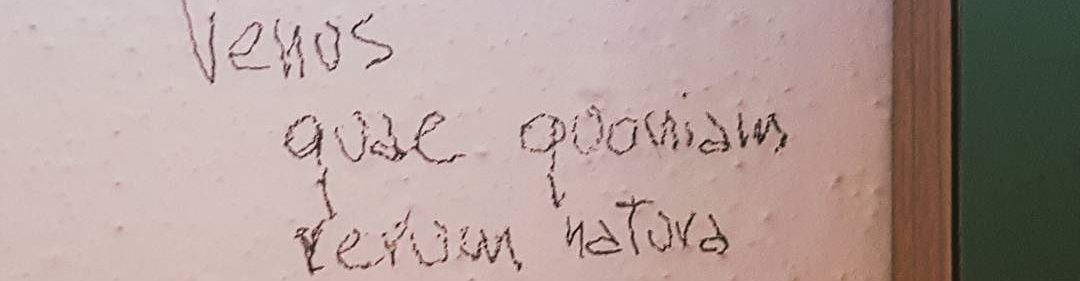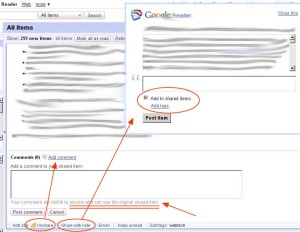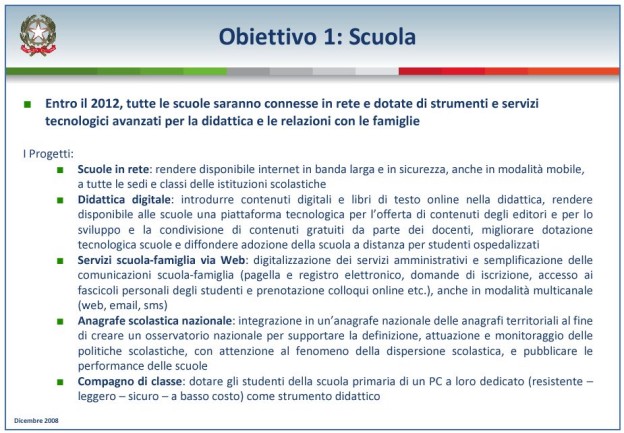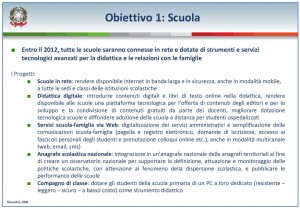Quale profonda visione metaforica della leggibilità del mondo può portare a raccontare così questo evento di cronaca, dove l’autobus corrisponde all’italia e il non-voler-scendere corrisponde al non-voler-essere-rimpatriati?
Ah, quando la grammatica sfugge e le parole parlano da sole – a parte il giornalista arruffone in buona o cattiva fede, intendo, che ci regala fughe interpretative decisamente poetiche.
Se volete, andate a leggere (e commentare) di là, l’articolo lo incollo qui tra qualche giorno.
____
Daniele Damele ha il pallino del filtro
Appena la risacca delle news giornalistiche riporta ciclicamente verso riva qualche episodio recente sui rischi di internet, ecco che prontamente Daniele Damele erompe in sentitissime lamentazioni sul degrado morale e sociale del giorno d’oggi, e quale soluzione taumaturgica propone sempre quest’accrocchio tecnico del filtro a monte che protegge i minori durante la navigazione su web.
Quelli tra voi più addentro alle cose tecniche, staranno sorridendo, lo so.
In queste settimane poi quelli della parte politica di Damele, a Roma e purtroppo al governo, stanno promuovendo squinternate proposte e disegni di legge (D’Alia, Carlucci, Barbareschi) da cui appunto si ricava come queste persone non conoscano né il funzionamento tecnico della Rete né abbiano chiarezza sulla portata dei propri effettivi poteri legislativi, ed è francamente spassoso (tristissimo, in realtà) vedere come vengano pubblicamente sbugiardati e ridicolizzati per la propria ignoranza e faciloneria anche dalla stampa internazionale e talvolta dagli stessi colleghi di corrente politica; vi rimando a Gilioli su L’Espresso per apprezzare l’ultimissima vis comica di Gabry Carlucci, mentre questo è il link dell’osservatorio giornalistico promosso da Apogeonline per tenere d’occhio gli sviluppi legislativi di queste cosiddette “leggi di internet”.
Ma torniamo agli accadimenti locali.
Sulla tematica del filtro alla navigazione, non intendo dilungarmi: dal punto di vista tecnico come dicevo non offre nessuna garanzia di blocco di contenuti riprovevoli, ma soprattutto innesca alcuni comportamenti decisamente controproducenti; ad esempio, per i quindicenni aggirare le imposizioni genitoriali è uno scopo di vita, e saltare i proxy e disabilitare filtri è esattamente quello che già fanno quando devono usare i loro programmi peer-to-peer. Se imposti una battaglia con gli adolescenti a base di divieti e proibizioni, innanzitutto perdi gli scontri regolarmente, e inoltre contribuisci alla formazione di una mentalità nel minore decisamente orientata al “vaffa” e al cercare di fregare gli adulti, al segreto e alla menzogna (e han ragione i giovanissimi, sia chiaro: questione di sopravvivenza).
Un dirigente scolastico poi che utilizza dei denari pubblici per acquistare delle soluzioni informatiche che limitano la libertà di navigazione senza offrire alcuna sicurezza informatica come contropartita, magari facendo tutto di testa sua senza informarne il Consiglio d’Istituto, compie un atto sbagliato, in relazione al messaggio pedagogico di una scuola laica. Il singolo genitore può legittimamente dar fiducia al filtro Davide e acquistarlo, ma nel caso di istituzioni pubbliche il discorso cambia. E’ come se gli acquisti dei libri per la biblioteca di un Istituto scolastico statale avvenissero solamente da cataloghi o in negozi approvati dalla chiesa cattolica, e non è un esempio a caso.
Il sito Davide inoltre comunica in modo piuttosto fumoso, soffermandosi parecchio su discorsoni di banale senso comune, ma senza portare delle prove concrete sull’efficacia delle proprie offerte informatiche: secondo voi la frase “la maggior parte dei filtri blocca al massimo il 65% dei siti non adatti ai minori. Davide.it ha un’efficacia fino al 95% con il più basso numero di errori” dice qualcosa di verificabile? Il 95% di cosa, di grazia?
Nel caso concreto, mettiamo il caso che il figlio di Damele minorenne al parco pubblico scopra nell’erba una rivista pornografica oppure venga avvicinato da qualcuno con intenzioni losche: probabilmente avvertirà il genitore, il quale chiamerà giustamente la polizia, la quale a sua volta intraprenderà delle indagini su ordine di un magistrato e magari terrà sotto sorveglianza gli afflussi di persone, ma di certo non chiuderà l’intero parco alla cittadinanza, come si vorrebbe ora fare con le “leggi di internet” se qualcosa di simile capitasse nei territori digitali dove oggi noi abitiamo con dignità di cittadini. Tutti noterebbero l’incongruenza e lo sproposito della reazione, nel ledere il mio diritto di cittadino di usufruire del parco pubblico rispetto al perseguire penalmente chi si è macchiato di un singolo reato, che rimane grave ovunque venga commesso.
Teniamo presente che Daniele Damele è giornalista, ed è perfettamente libero di credere e di promuovere quello in cui crede, foss’anche riducendo la sua professione a quella di tragicomico acritico tamburino locale delle scelte politiche targate PdL, nel momento stesso in cui vengono promulgate qui in Italia leggi liberticide promosse da personaggi di nessuna credibilità e di nessun competenza.
Capite quindi come quella di Damele sia una voce autorevole in virtù delle cariche pubbliche da lui ricoperte, ovvero in grado di orientare le coscienze di molte persone nella considerazione di queste tematiche etiche legate alle libertà individuali di opinione e di pubblicazione, indici sicuri del livello di civiltà raggiunto da una data collettività; a maggior ragione potrete comprendere come sia molto grave, per questi stessi motivi, che dal suo alto pulpito Damele continui da anni a reclamizzare (spero per lui in modo dichiaratamente remunerato, almeno) una determinata soluzione tecnica, di per sé palliativa e censoria quindi non educativa, quale risposta adeguata alla pericolosità dell’ambiente Internet per le giovani generazioni.